Sono giovani, non vogliono essere chiamati eroi e non pensano di aver fatto nulla di diverso dal proprio dovere. Sono medici e infermieri che a pochi giorni dalla laurea hanno sperimentato sulla propria pelle cosa vuol dire gestire in emergenza una pandemia mondiale.
Ecco le nostre interviste

Salvatore si è laureato in Infermieristica a Firenze il 21 ottobre, il giorno dopo ha fatto il colloquio a Careggi, il 30 ha indossato e sperimentato per la prima volta la difficoltà di lavorare e respirare dentro una tuta anti Covid.
Salvatore è entrato in un reparto di medicina ad alta intensità che in meno di una settimana è stato convertito in una sub intensiva Covid: “Mi sono trovato a gestire caschi e ventilatori. All’inizio mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Mi ha aiutato la grande collaborazione che si è subito instaurata, i corsi dal vivo con i professionisti che ci hanno fatto sono stati fondamentali ma l’impatto è stato molto forte . Non abbiamo avuto il tempo di realizzare cosa stesse accadendo e la prima settimana è stata molto dura. Nel reparto correvano tutti, tutti sembravano sapere esattamente cosa fare, io invece il reparto non lo conoscevo e temevo di non essere all’altezza”.
Giorno dopo giorno la paura dell’inadeguatezza si è dissolta, anche perché non c’era tempo per pensare, serviva massima concentrazione per non correre il rischio di contagiarsi e togliere una risorsa al reparto: “Ho sempre messo la massima attenzione in ogni gesto ma ero consapevole che poteva non essere sufficiente. Molti colleghi si sono ammalati, quando si gestiscono i caschi (sistemi di ventilazione assistita non invasiva utilizzati nelle terapie intensive e sub intensive, ndr) il rischio di essere contagiati da un paziente è alto, basta un attimo”.
La paura, lo stress, i turni massacranti dentro scafandri dove si suda, non si sente, in cui la vista si appanna. A questo Salvatore e i tanti infermieri e medici assunti per fronteggiare l’emergenza si sono dovuti abituare in fretta: “Mi sono trasferito a Firenze per studiare Medicina a Firenze, la mia famiglia è di Catania, ogni giorno mi chiamavano preoccupati, mi chiedevano come era andata la giornata e si raccomandavano di stare attento”.
Raccomandazioni normali per ogni genitore con figli lontani, tanto più se quel figlio vive ogni giorno a rischio Covid: “Non è facile ma alla fine di ogni giornata, anche in quella prima settimana, sapere di aver fatto il mio dovere, di aver dato il mio contributo mi ha permesso di andare avanti . Oggi lavoro al Covid Center di Careggi, lavoriamo molto d’equipe, ci sono medici e infermieri giovani come me e tutti siamo pronti per affrontare la situazione”.
Il Covid non è entrato solo negli ospedali. Le case di riposo sono state le realtà tra le più colpite soprattutto nei primi mesi della pandemia.
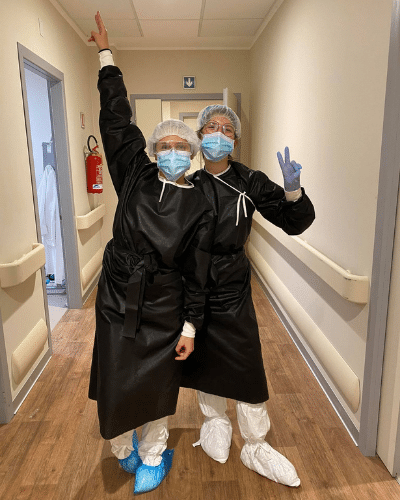
Martina ha 23 anni oggi, laureata in Infermieristica a dicembre 2019, a gennaio 2020 ha preso servizio in una casa di cura per anziani a Impruneta (Firenze). Un mese appena poi anche per lei è iniziato l’inferno: “Quando sono entrata nella struttura era tutto normale, si iniziava a sentire parlare di Covid ma sembrava una cosa lontana, era come assistere al racconto di un film apocalittico, mai avremmo creduto che di lì a poco ci saremmo trovati dentro quel film”.
Anche per Martina il tempo per realizzare è stato poco: “Se ripenso a quei primi giorni a volte ho la sensazione siano ieri, altre una vita fa. Oggi è diventata la nostra normalità”.
“Le malattie infettive sono sempre esistite però prima sapevi che c’erano delle accortezze che potevi adottare per tutelarti. Pensiamo all’HIV, è anche quella una malattia infettiva. Un infermiere sa che se si buca con un ago infetto può correre il rischio di contrarre il virus, con il Covid è diverso, nessuno sa da che parte possa arrivare, non c’è un campanello d’allarme”.
Mi sono trovata a fare 25 giorni senza mai un giorno di riposo, una sera ho rischiato anche la vita in autostrada per la stanchezza ma non chiamateci eroi, siamo professionisti, non siamo missionari, questa professione deve essere valorizzata adeguatamente
E sono stati tanti i sanitari che hanno sperimentato sulla propria pelle gli effetti del Covid, anche tra i colleghi di Martina: “Soprattutto nei primi tempi, quando ancora non c’erano protocolli chiari, quando i dpi (dispositivi di protezione individuale, ndr) scarseggiavano, quando ci rifornivano solo di mascherine chirurgiche e non avevamo camici, erano tanti i colleghi ad ammalarsi. È stato sicuramente quello il momento più duro. I colleghi si ammalavano e non ne arrivavano altri. Mi sono trovata a fare anche 25 giorni senza mai un libero (un turno di riposo). Il momento in cui ho capito che ero allo stremo? Una sera, stavo rincasando, avevo appena smontato da un turno di 12 ore, ero in macchina e a pochi chilometri dall’uscita del casello autostradale ho avuto un colpo di sonno. Ho rischiato di uccidermi contro un guard rail per la stanchezza ”.
Martina però non vuole essere compatita: “Non siamo eroi, è stata bella la solidarietà che l’Italia tutta ci ha dimostrato ma la nostra non è una missione, ci siamo formati e abbiamo studiato tanto per affrontare queste situazioni, siamo professionisti È importante che passi il messaggio che la nostra è una professione e lo è sempre stata anche in passato, la differenza è che quest’anno se ne sono accorti anche fuori. La sanità deve essere valorizzata, adesso paghiamo i tagli del passato : servono ancora tanti medici e infermieri e servono stipendi adeguati, almeno in linea con la media europea, sono passaggi importanti per inquadrare correttamente la nostra professione, una professione che ti dà molto, mi commuovo se ripenso a certi momenti passati quest’anno, alla forza che con i colleghi ci infondevamo a vicenda, alle battute che cercavamo di non farci mancare sia per noi che per i pazienti, e ogni volta che un ospite si negativizzava gli applausi riempivano le stanze, ma è anche una professione che mette a dura prova, mette a rischio te stesso e i tuoi affetti”.
Oggi Martina lavora nell’ospedale di Borgo San Lorenzo. “Cosa mi ha insegnato quest’anno? Ho riscoperto la mia fragilità, ho imparato ad essere forte anche grazie alla mia fragilità”.
Il timore di diventare loro stessi veicolo di contagio. Questa è la preoccupazione che li accomuna tutti.

Giulia, medico, dopo la laurea a Pisa per buona parte del 2020 ha lavorato nelle USCA (unità speciali di continuità assistenziale) in Val di Cecina e per non avere contatti con la famiglia si era isolata in una parte della casa, oggi si è trasferita a Milano dove si sta specializzando in nefrologia e dialisi : “In realtà – racconta – tutt’oggi che vivo e lavoro a Milano quando rientro a casa a Pomarance nel week end presto servizio nelle Usca, il contratto lo permette e so che qui c’è un gran bisogno di personale”.
“Mi sono laureata in Medicina a Pisa a settembre 2019, ad aprile 2020 sono entrata nelle Usca. Ci occupavamo – e ci occupiamo – di pazienti positivi che non hanno bisogno di ospedalizzazione e che possono essere curati a casa. Di solito le giornate si articolano così: la mattina controlliamo gli esiti dei tamponi del giorno precedente, poi iniziamo il giro delle telefonate ai pazienti per accertarci delle loro condizioni di salute, nel pomeriggio iniziamo le visite a domicilio”.
Oltre alla pandemia, molti di questi ragazzi, proprio come Giulia, durante l’emergenza hanno portato avanti anche gli studi e la formazione professionale. Cosa ti ha spinto a non mollare? “In agosto, tra gli studi per la specializzazione, il caldo, la stanchezza accumulata a volte ci ho pensato a lasciare il lavoro nella Usca ma poi mi dispiaceva perché per il territorio sono un aiuto fondamentale e ce ne rendiamo conto molto bene quando andiamo a visitare a domicilio gli anziani: l’unica cosa che di noi Usca si intravedono sono gli occhi ma a loro bastano. La maggior parte delle volte durante le visite loro non erano interessati alla terapia, avevano più bisogno di trovare conforto nei nostri occhi, chiedevano umanità più che una cura. E poi questo è il mio lavoro, il lavoro che non mi sono mai pentita di aver scelto . Quando incontri una persona guarita dal Covid che hai curato che ti saluta per strada e ti ringrazia, sei ripagato da tutti i sacrifici”.

