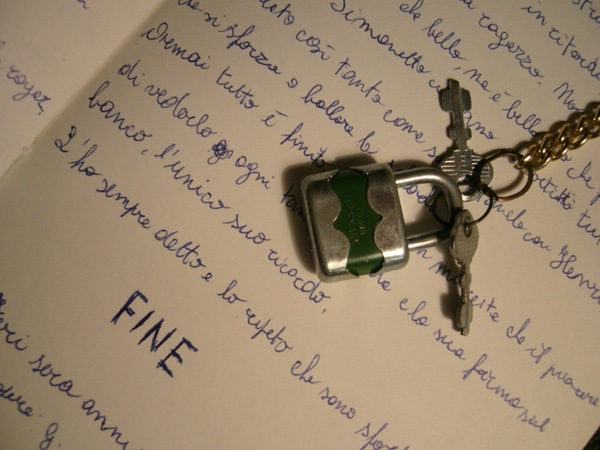Dunque un intellettuale pacifista costretto a rinunciare alla politica sceglie il mestiere più bucolico: la pastorizia.
La decisione di partire per la Turchia aveva avuto un effetto dirompente e trainante. Affascinati dall’idea, tutti volevano venire con noi.
Brunora aveva implorato mamma di portarla con sé: così ci sarebbe stato almeno una che di pecore se ne intendeva... E dire che era venuta via dalle Bagnore per andare a Parigi e non fare più la pecoraia...
Ma anche Germaine aveva deciso che non poteva lasciarci partire così. Voleva venire con noi a tutti i costi e Giovannoni, rassegnato, le aveva finanziato il viaggio, convinto che l’avrebbe rivista presto. E infine c’era Arturo, da me detto "Tutur", il ciabattino anarchico e cieco da un oc¬chio, emigrato in Francia da molti anni, ormai parigino al cento per cento e assiduo frequentatore di bistrò, che, per seguire l’amico Ezio, aveva liquidato la bottega.
Babbo ci aveva preceduto a Istanbul, per organizzare l’alloggio ad Erenköy, un paesino della costa anatolica a pochi chilometri da Istanbul. Così, non appena ci aveva dato il via, questa specie d’armata Brancaleone s'era imbarcata a Marsiglia per Istanbul.
Cercate d’immaginarvela, questa équipe di aspiranti "pastori erranti nell’Asia"... Minore consistente in una bambina bionda e paffutella di quasi sei anni, una giovane donna bruna di meno di venticinque, una ragazza del Monte Amiata, una giovane signora parigina bionda e truccata, con tacchettini e cappellini, un ciabattino di mezza età, guercio e gioviale, e infine una vecchina asciutta, senza denti, ma molto distinta e ordinata, in quel suo vestire senza moda e senza epoca, con le gonne fino ai piedi e con tutti i suoi bauli, il suo letto di ferro e il fonografo a tromba.
Allo sbarco ci fu un leggero intoppo con le autorità turche, perché leggendo Isa sul passaporto, pretendevano che fossi un maschio, mentre io ero inequivocabilmente femmina. Fu così che si scoprì che Isa in turco vuol dire Gesù con grande soddisfazione di mamma che, quand’era incinta (e allora non si sapeva in anticipo il sesso del nascituro) si era messa in testa che se fosse nato un maschio lo avrebbe chiamato Gesù. Così c’era stato un gran moto di sollievo quando ero nata io, femmina, salvandomi da dover portare un nome così impegnativo.
Ora alla dogana turca babbo disse: "Eh, quando si mette in testa una cosa lei..."
Appena arrivato in Turchia, nel dicembre del '27, babbo aveva investito nell'acquisto di cinquecento pecore praticamente tutti i pochi ricavati dalla vendita dei mobili di Genova e dalla riscossione degli ultimi crediti della sua professione d’avvocato, che nonna Ida era riuscita a riscuotere prima di lasciare l’Italia.
Oltre alla casa dove alloggiavamo, a Erenköy, aveva affittato un ovile su una collina poco distante a Içerenköy (che sarebbe come dire Erenköy alto, più all’interno). Contrariamente alle disastrose descrizioni che babbo ce ne aveva fatto, la casa risultò essere una deliziosa costruzione in legno a un piano, costeggiata da una loggia coperta di glicine. La porta d’ingresso era al cen¬tro della loggia e le stanze si affacciavano di qua e di là. Lì eravamo alloggiati tutti eccetto Germaine, che aveva pensato bene di stabilirsi in una pensioncina in città ed aveva trovato subito due corteggiatori, un giovane medico turco bruno, il dottor Hikmet, e un giovane architetto greco biondo, Dimitri Petussi, dai quali si faceva accompagnare alternativamente, per venirci a trovare in campagna. […]
Mamma, Brunora ed io andavamo a badare alle pecore. Ci doveva essere anche un pastore turco, che, a quel che mi raccontava Brunora, quando l’ho rivista tanti anni dopo sul Monte Amiata, voleva a tutti i costi sposarla. Come si capissero non lo so. Babbo credo che più che badare alle pecore leggesse le Bucoliche di Virgilio e dava lezioni di francese al figlio del padrone di casa (oltre a continuare a mandare al Sig. Maloubier le traduzioni co¬minciate a Bruxelles). Naturalmente avevamo anche un cane da pastore. Si chiamava Flick. […]
Poco dopo il nostro arrivo, babbo venne chiamato a Istanbul dalla polizia turca. Andò tutto in ansia, temendo di essere espulso anche da lì. Invece furono molto gentili e gli dissero che erano informati della sua venuta, dei suoi precedenti e che gli assicuravano la possibilità di soggiornare indisturbato in Turchia, a patto che s’impegnasse a non svolgere attività politica. Purtroppo il 1928 fu proprio l’anno in cui il patrimonio ovino della Turchia fu decimato dal colera delle pecore. Ho ritrovato a Cennina un’agendina in cui babbo aveva annotato con la bella calligrafia ordinata la contabilità della sua impresa. E fa stringere il cuore leggervi. […]
In quegli anni, e per tutti i successivi del nostro soggiorno in Turchia, babbo cercava di compensare la rinuncia alla politica, approfondendo i suoi studi umanistici e la conoscenza della storia e dell’evoluzione del paese che ci ospitava. Era un momento di gran fervore per la giovane Repubblica Turca. Atatürk era un dittatore illuminato, e mirava alla modernizzazione e alla europeizzazione del suo Paese.
La riforma dell’alfabeto entusiasmava babbo. L’alfabeto arabo, aveva reso la cultura monopolio di pochi privilegiati, soprattutto dei religiosi. Proprio negli anni del nostro arrivo Atatürk aveva sostituito i caratteri arabi con l’alfabeto latino, con regole fonetiche molto semplici e razionali, per adeguarlo a tutti i suoni della lingua turca. In quegli anni si procedeva radicalmente all’alfabetizzazione. Nelle piazze dei villaggi i soldati insegnavano a leggere e scrivere a tutti gli abitanti di età superiore ai sei anni. Nei quartieri delle città vari locali erano stati adibiti a Dershane (Edificio per l’insegnamento), dove andavano ad imparare l’alfabeto i giovani e gli anziani, le nonne coi nipotini in braccio. C’era una grande sete d’apprendimento: prima solo il 2% della popola¬zione sa¬peva leggere, e ci volevano sei anni per imparare a leggere e scrivere. Ora, col nuovo alfabeto, si poteva imparare in sei mesi!
§Atatürk aveva anche abolito tutti i privilegi del potere religioso e per eliminarne anche i segni esteriori, aveva proibito i fez e il velo per le donne. Lui stesso andava ad insegnare a leggere e scrivere nelle piazze, e se incontrava una vecchietta recalcitrante, ancora con la testa coperta, cercava di spiegarle pazientemente che quelli erano segni di superstizione che impedivano l’evoluzione e il progresso della nazione. La Turchia fu il primo paese a dare il voto alle donne. […]
Il 6 gennaio 1931 giorno della Befana, era morta a Grosseto nonna Assunta, la mamma di nonna Amelia, e nonna Amelia era tornata in Italia per correre al suo capezzale. In una lunga lettera scritta in quest’occasione, mamma diceva tra l’altro
...cerca d’informarci dettagliatamente su quello che hai visto e anche di come vanno le cose in Italia, del costo della vita e dell’umore del popolo -e più avanti- Mi fa tanto male essere lontani da voi quando vedo che il tempo passa e che vorrei si fosse tutti riuniti! Chi ci renderà tutti questi anni che abbiamo perduto?
Nel ’32 i Quaccheri alla fine dell’anno scolastico chiusero il Liceo di Caddè Bostàn, mentre quello femminile di Scutari continuò per alcuni anni. Così in ottobre decidemmo di trasferirci in città in un appartamentino a pianterreno - con la cucina nel seminterrato - proprio davanti alla Scuola Italiana e al Consolato Italiano, a Beyoglu, Sefer Bostan Sokak N. 2. La scuola di Scutari era per babbo facilmente raggiungibile, bastava attraversare il Bosforo con un vaporetto, e ce n’erano ogni momento, come prendere un autobus. D’altra parte la collaborazione al giornale della colonia italiana si era andata am-pliando. Il Direttore Gilberto Primi pubblicava anche un quotidiano in lingua francese, destinato alla colonia europea francofona, il Beyoglu, ed era stato bel lieto di scaricare su babbo l’intera responsabilità della redazione del Messaggero degli Italiani, quindicinale ufficiale della colonia: Il Messaccero delyi Italyani, come era scritto sulla testata, ottemperando all’obbligo di riportare il titolo anche con la grafia del nuovo alfabeto turco. Salvo che per la parte politica, che si limita a riportare le "veline" del partito e gli articoli di propaganda ufficiale, e senza mai fare apparire la propria firma, babbo ne diventa praticamente redattore unico. Gli dà un ampio respiro culturale, approfondendo tutti gli aspetti storici e letterari dei rapporti italo-turchi dall’antichità al presente. Perché non ci si accorga che è un’unica persona a fare il giornale, firma i numerosi articoli e le rubriche da lui create con diversi pseudonimi: Alizio Bertani, Aliberto Ziani, Tiberio Alzani -tutti anagrammi- e persino Anatolio Sansavino. Turan Altay è lo pseudonimo con cui firma certe finte novelle turche che scrive quando non gli arrivano in tempo le traduzioni degli autori turchi che ordina ai suoi allievi per la rubrica La Novella turca. A questa alterna La Novella italiana, dove, se la novella è sua, è firmata di solito Aliberto Ziani. […]
In occasione del congresso per la riforma della lingua turca, babbo aveva fatto un breve intervento a favore delle teorie di Atatürk, mettendone in risalto soprattutto il valore politico (poiché il valore scientifico poteva essere discutibile); se l’era fatto tradurre e lo aveva letto in turco. Questo aveva impressionato molto positivamente il presidente della Repubblica, che gli fece affidare la cattedra d’Italiano e di Latino alla Facoltà di Lettere, nel corso obbligatorio per gli studenti di Romanologia. Quando poi passò la riforma del codice ottomano e ne venne adottato uno nuovo, ispirato al nostro Codice Zanardelli, venne fondata, nel 1934, la nuova Facoltà di Giurisprudenza e venne istituito un corso di Latino, necessario perché gli studenti potessero capire le terminologie del Diritto Romano. Grazie alla sua laurea in Legge, anche questo corso venne affidato a babbo. Sebbene si trattasse di un corso libero, le lezioni erano affollatissime e il professore godeva di grande popolarità. […]
Ma la cosa più bella m’è capitata più di quarant’anni dopo, durante una vacanza in Turchia. Era il 15 agosto del 1978 ed eravamo partiti Andrea e io in macchina la mattina presto da Bodrum per arrivare a ora di pranzo a Kusadasi. Tra soste al mercatino di Milas e in vari siti archeologici che s’incontrano nel percorso, si era fatto mezzogiorno ed eravamo ancora a Söke, un’anonima citta¬dina non turistica dell’interno, dove c’eravamo fermati a comprare da un artigiano dei coccetti di una terracotta così primitiva da sembrare preistorica. Stavamo per ripartire quando vedo, nella vetrina di un poverissimo negozietto di bakkal, delle bottigliette di Visne suyu, acqua di visciole, una spremuta di amarene, che lì si trova dappertutto e che è il più buon succo di frutta e il più dissetante che sia mai stato prodotto. Sapendo che Andrea ne andava matto gli propongo di berne uno ed entriamo. Nel minuscolo negozio c’è un solo avventore: un ragazzo di una ventina d’anni, che, deferente verso la straniera, mi dà la pre-cedenza. Ringrazio e ordino le due bibite. Come succede sempre quando mi sentono parlare turco, mi fanno la solita domanda: "Come mai parla così bene turco?" E io do la solita risposta: "Sono stata in Turchia da bambina, tanto tempo fa... Ai tempi di Atatürk", aggiungo. Allora interviene il giovane e, come se rac¬contasse un’antica leggenda, dice: "Ai tempi di Atatürk c’era anche un altro italiano, molto in gamba, a Istanbul, che era scappato da Mussolini e aveva fondato la Facoltà di Diritto Romano: si chiamava Professor Bartalini..." "Era mio padre..." riesco a dire. Per l’appunto quel ragazzo era uno studente di legge, venuto in vacanza da Istanbul. Evviva il Visne suyu!
[Brani tratti da “Lontana terra. Diari di toscani in viaggio”, Terre di mezzo, Milano, 2005]