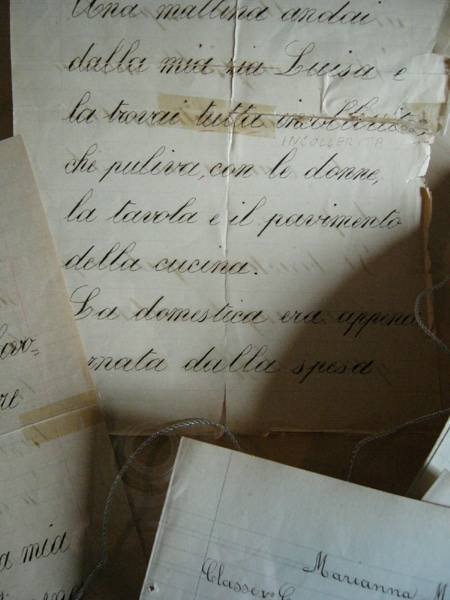Ero in stato interessante avanzato, e così coinvolta dalla straordinaria situazione che avevo scelto di vivere, che ero già tutta proiettata, completamente tesa, al mio punto di arrivo, tanto da non essere più partecipe di quanto mi circondava.
Del mio punto di arrivo sapevo solo una cosa certa: là c’era mio marito ad aspettarmi. Altro non sapevo; immaginavo tutto ed avevo una grande paura, uno sgomento che non si poteva raccontare a nessuno, perché io avevo voluto quella situazione che comportava una rottura con il mondo al quale fino allora avevo appartenuto, io avevo voluto quel distacco, io avevo scelto quel marito.
Ma la paura era tanta, era la paura dell’ignoto; là c’era solo lui a cui potevo riferirmi, il resto era tutto un’illazione, una supposizione, perché potevo immaginare qualsiasi cosa di quel mondo nuovo in cui andavo. Non ero certo la prima a recarmici, ma io ero gravata dalle decisioni che avevo preso e dalle conseguenti responsabilità assunte, verso me stessa, verso mio marito, ma sopratutto verso il bambino che doveva nascere.
Senza dubbio anche mio marito era preoccupato, ma lui si trovava nel suo paese, per lui l’ignoto ero solo io, un episodio. Poi c’era quella lacerazione: non partivo come può partire una persona che va, affronta il viaggio con il viatico di tutti i parenti, perché dovrà sopportare molti disagi. No, io avevo dato un taglio netto a tutto e a tutti, per cui non c’era il conforto di nessuno, ero proprio sola. Mi dava forza sapere di attendere un figlio, perché non mi consentiva di indulgere nei miei sgomenti. […]
Cominciammo ad atterrare. È Mogadiscio, si, è Mogadiscio! Ed io guardo, guardo dal finestrino e vedo solo degli arbusti. L’aereoporto? Non lo vedo. Si atterra. Solo una volta scesa avrei capito che l’aereoporto di Mogadiscio era una baracca di legno verde in condizioni simili a quella di Aden. Seduta in una delle poltrone della prima fila, fui l’ultima a scendere, anche perché indugiai volutamente, per essere certa di trovarmi in buone condizioni, le migliori possibili: pettinata, a posto il vestito, a posto tutto. Uscii e sulla porta dell’aereo mi guardai intorno e vidi venirmi incontro mio marito seguito da una grandissima folla che urlava, soprattutto le donne emettevano un grido, che poi seppi essere caratteristico di festa, ottenuto muovendo molto velocemente la lingua tra le labbra. Ero molto confusa e stordita. Ricordo solo la gioia di rivedere mio marito, bello e confortante. Mi disse: "Ma come? Non scendevi mai?" Forse per un attimo aveva avuto paura che non ci fossi. Ora, dopo tanti anni, penso così. Poi vennero compiute in fretta tutte le operazioni di dogana, mentre ero sempre in mezzo a tutta quella gente che mi faceva ala quando passavo.
Ma non avevo ancora compreso che tutti erano lì per me. Migliaia di persone venute per salutarmi, migliaia. Le aveva mosse la curiosità, forse la simpatia, in una affettuosa partecipazione corale alle emozioni di mio marito. Molta era gente della sua tribù, il mio arrivo si poteva considerare una specie di matrimonio. Fui accolta con molto onore, ma in quei primi momenti ero confusa e imbarazzata, felice solo di ritrovare lui. Poi sarebbe venuta la curiosità di conoscere la sua gente, il desiderio di farmi accettare. Non avevo riserve, anche se capivo quanto diversi fossero da me. La scelta che avevo fatto mi aveva diviso dai miei e nella solitudine in cui ero c’era la speranza di trovare tra loro gli affetti che avevo perduto.
Quasi senza rendermene conto, fui presa, trasportata, condotta a casa di mia cognata che mi avrebbe ospitato per tutto il tempo che avessi voluto, perché la famiglia desiderava che rimanessi a Mogadiscio.
Così arrivai alla loro casa che si trovava nella via più importante della città, che era anche la più bella, quella che iniziava con il Consolato e terminava con l’Ambasciata italiana. I parenti abitavano il una baracca di legno, un bungalow. Quel piccolo bungalow aveva un ingresso, poi un corridoio, su un lato del quale si aprivano tutte le stanze, mentre sull’altro c’era un cortiletto con un bagno. Il tutto in condizioni primitive. Mi sarei accorta in seguito che tutta la Somalia era in tali condizioni e che nelle case vi era solo lo stretto indispensabile per vivere. E in ambienti simili vivevano gli Europei, come alcuni Somali privilegiati o gli orientali. L’avrei scoperto piano piano.
Illusioni non me ne ero fatte, né mio marito mi aveva minimamente mentito su quanto mi aspettava dalla mia scelta di una vita con lui. Avevo passato notti intere ad immaginare la capanna che forse mi avrebbe accolto, cercando, con la mente, di sistemarla ed arredarla in modo tale da renderla confortevole, ed in quei miei inquieti pensieri avevo deciso che avrei coperto tutte le pareti con stuoie di paglia, che stranamente - l’ho notato dopo - erano come quelle che realmente si confezionavano sul luogo.
Ero preparata al peggio con grande determinazione, perché la scelta era stata cosciente e difficilissimo sarebbe stato tornare indietro, ma mi resi conto che ogni volta che mi trovavo davanti la realtà non potevo sottrarmi allo sgomento. Sgomento che consumavo in solitudine e che cercavo di trattenere nel più profondo di me, fingendo spesso a me stessa di non averne coscienza. Entrare in quella casa, la prima che visitavo in quel nuovo paese, non calmò le mie inquietudini, anzi le rinnovò. Era diversa da quelle in cui avevo vissuto sino ad allora e mi mortificava. In essa vivevano la famiglia di mia cognata e la famiglia dello zio di mio marito Abdullahi, un uomo dolce, sempre ragionevole e molto affettuoso, a quel tempo poco più che trentenne. Alla sua volontà mio marito doveva i suoi studi.
Gli abitanti erano in molti per la capienza della casa e a loro si aggiungevano non solo fratelli e sorelle che per periodi più o meno lunghi, oppure fissi, vi soggiornavano, ma si aggiungevano gli ospiti che quotidianamente si presentavano, sì che ogni angolo era sempre utilizzato al massimo per sopperire alle esigenze primarie di tutta quella gente.
Alla capanna ero pronta, ma a questo no, non volli neppure prendere in considerazione la possibilità che forse avrei dovuto dividere anche la capanna con altri in un contatto continuo che toglieva qualsiasi volontà di privato e personale. Quella gente sconosciuta, quasi sempre mal vestita, che si muoveva con ritmi e modi a me assolutamente estranei, dovevo imparare a viverla. Avevo alcune mediazioni in quell’impresa difficoltosa, anzitutto l’amore che portavo a mio marito, poi una curiosità che sempre mi ha spinto con candore verso tutto, ed infine il senso dell’avventura maturato in un'infanzia di letture, non esclusi i fumetti di Tarzan. […]
Cominciava il mio viaggio nel cuore dell’Africa, l’Africa Equatoriale.
Usciti da Chisimaio, che era poco più di un grosso villaggio, con poche costruzioni in mattoni e molte in paglia, imboccata la strada rossa che, fiancheggiando il mare, accompagnava verso l’interno, cominciai a sentire profondamente il fascino di quella terra, e presi coscienza che era stata da sempre dentro di me. In quel primo viaggio mi sembrava di non conoscere, ma di riconoscere tutto. E quella casa, quella casa quando compariva? Dietro la svolta, finalmente, il paese, Jonte! La strada fangosa passava in mezzo a povere capanne. Vedemmo la Missione, col suo cancello pulito, la Missione così perduta.
Un altro chilometro e finalmente la casa! Fu veramente una gioia. L’amai subito quella piccola costruzione sotto un grandissimo tamarindo, che poi scoprii pieno di buceri beccogiallo: una meraviglia! Era stata la prima Missione cristiana all’interno dell’Africa orientale, una missione svedese, e ancora conservava in un angolo del giardino un piccolo, piccolissimo cimitero con quattro o cinque lapidi che ispiravano una malinconia infinita. Il complesso si componeva di due edifici in stile moresco con il tetto in eternit: uno per abitazione e uno per foresteria, più una piccola cucina, esterna, come quasi sempre nelle case lontane dalla città. Dietro aveva, ad una cinquantina di metri, il campo degli operai, con cinque o sei capanne circolari ed una piccola baracca dove stavano i poliziotti in servizio nel paese. In più c’erano i capannoni per le attrezzature e per il motore che dava l’elettricità.
Un grande viale collegava i vari edifici riuniti su di una specie di piccolo terrapieno, con un fitto mangheto, che si sviluppava proprio sulla riva del fiume. Il viale dal mangheto alla casa era tutto fiancheggiato di grandi crotus, verdi, gialli o punteggiati di rosso e di alberi chiamati frangipane dai fiori bianchi. […]
Ancora estranea a tutto, mi possedevano un’ansia ed un’angoscia che non esternai mai a mio marito né ad altri. Ero inquieta in quella casa confortevole, accogliente anche se piccola e modesta, completamente isolata a quindici chilometri dalla linea dell’Equatore, in mezzo alla savana. I primi tempi furono veramente molto faticosi. Terribili di silenzio, perché non potevo, non volevo parlare né lamentarmi con nessuno, neppure con me stessa. Ricordo soprattutto la sera, quando dovevo andare a letto, spesso senza luce. Il gruppo del nostro motore per l’elettricità veniva fermato alle nove.
Nella nostra camera tenevamo una piccola lampada a petrolio, di quelle chiamate fanus, proprio per non stare completamente al buio, immersi. La sera scendeva prestissimo e non c’era crepuscolo, era buio di colpo. Quando arrivai erano notti senza luna, notti infinite, spesse e dense come solo là ho visto. Un buio che quasi si materializzava. Scesa la sera, la giornata era completamente finita. Cenavamo, chiacchieravamo con i nostri operai; poi, per non consumare inutilmente l’energia, il motore veniva spento, quando non lo era già perché guasto, cosa che accadeva spessissimo. Andavamo a letto presto con il nostro lumino a petrolio e la mattina ci alzavamo prestissimo ed era bello levarsi, andare sulla porta di casa e scorgere in quella nebbiolina di umidità, che ancora aleggiava a filo d’erba, i tanti uccelli della fauna equatoriale: il pellicano, l’ibis, la spatola ed altri che si muovevano e camminavano.
Era uno spettacolo che ogni mattina si rinnovava, una realtà più bella di qualsiasi sogno. Quello era il momento magico della giornata, la mattina, era la speranza, ma io avevo dentro sempre quel nodo, la notte. La paura della notte, la paura del buio, di sentirmi sola in quell’infinito. Trascorreva così la mia giornata in piccole attività fra gente che veniva a salutarmi, ma subito dopo pranzo mi prendeva l’angoscia, l’ansia terribile che presto sarebbe venuto buio, quel buio che mi soffocava, perché era pieno di rumori inquietanti ed evocativi. Era tutta l’Africa intorno che si faceva sentire: dal tam-tam continuo, continuo, martellante, da una zona all’altra, da una notte all’altra, all’urlo di tutti gli animali. Ed io, in quella casa in fondo fragilissima, senza neppure i vetri alle finestre, solo con persiane ed una retina contro le zanzare, forse le più pericolose di tutti gli animali della zona, mi sentivo molto esposta. Ed ero lì in attesa dell’elefante, del leone, che entrassero con la testa in camera. Notte dopo notte, con le orecchie tese. Con molta cautela - non volevo impensierire mio marito - chiedevo ad ogni rumore: "Che animale è questo? È la jena?" Non so perché la jena era quella che mi dava più inquietudine. Se gracidava una rana subito domandavo: "Scusa, ti pare di aver sentito una jena?" Mio marito mi orientava piano piano, diceva: "No, questo è l’ippopotamo; no, questo è un uccello; queste sono rane". E poi finalmente: "Si, questa è la jena". Allora finì la mia tensione: una volta individuato l’urlo lugubre della jena, sempre evocativo e sgradevole, improvvisamente mi tranquillizzai.
Cominciai a prendere confidenza con i rumori della notte, cominciai a prendere confidenza con l’Africa.
[Brani tratti da “Lontana terra. Diari di toscani in viaggio”, Terre di mezzo, Milano, 2005]